L’arte ci prende per mano M. Lai Quando l’artista Maria…
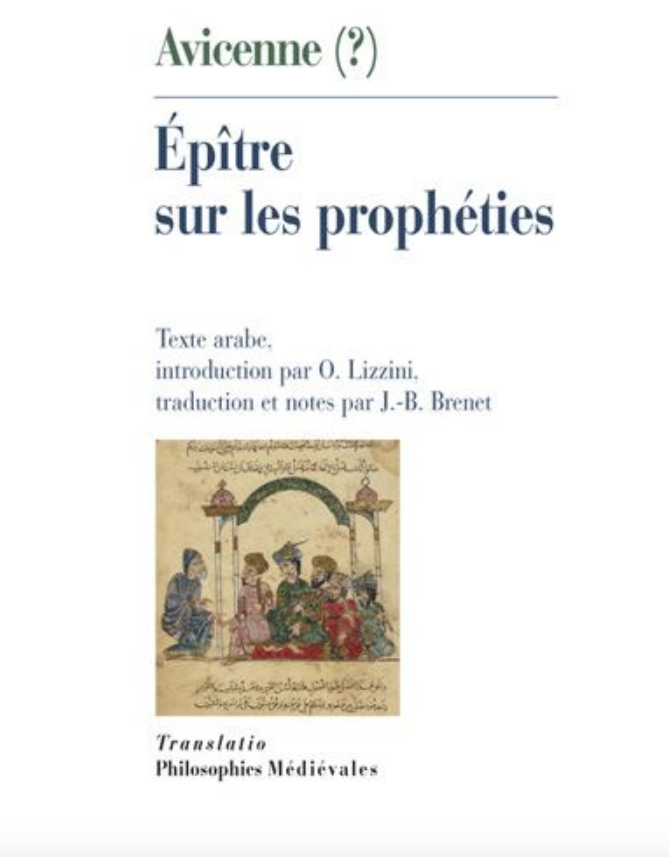
Olga Lucia Lizzini, Jean-Baptiste Brenet AVICENNE (?), Épître sur les prophéties
—> recensione di Massimiliano Lenzi
L’agile volume, in formato tascabile, curato da Olga Lucia Lizzini (introduzione) e Jean-Baptiste Brenet (traduzione e note) e apparso per i tipi di Vrin nella collana «Translatio.Philosophies Médiévales»,è costituito da una traduzione francese con testo arabo a fronte (pp. 85-117) e ricco apparato di note (pp. 119-167) dell’Epistola sulle profezie(opera generalmente, ma non unanimemente, attribuita ad Avicenna), da un ampio saggio introduttivo sul tema della rivelazione profetica in Avicenna (Le langage de Dieu: révélation et prophétie chez Avicenne), e da una ricca sezione bibliografica, a cui sono da aggiungere una nota del traduttore (pp. 83-84) e un indice generale (p. 197). Di questa Epistola esiste, come segnala Brenet, una traduzione inglese di Michael Marmura (che è anche l’editore del testo arabo su cui è condotta la traduzione francese) e una italiana della stessa Lizzini, comparsa nel volume Angeli. Ebraismo Cristianesimo Islam, a cura di G. Agamben e E. Coccia, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2009, alle pp. 1894-1918. Brenet segnala inoltre che il testo arabo da lui tradotto è un testo semicritico, i cui difetti ne rendono in più luoghi congetturale la comprensione e, di conseguenza, la traduzione, oltre a comprometterne qualsiasi conclusione in merito alla possibile attribuzione. Di qui sia la decisione, che accresce il valore critico di questo lavoro, di discutere e talvolta intervenire anche sul testo arabo, optando per lezioni diverse da quelle adottate dall’editore e segnalandolo nell’apparato delle note (dove serrato è anche il confronto con le altre traduzioni disponibili, in uno sforzo costante di comprensione nel quale il piano della traduzione non è mai disgiunto da quello dell’interpretazione); sia la scelta, in mancanza di uno studio critico del testo, di procedere con cautela sulla questione dell’autenticità (o dell’inautenticità), scelta icasticamente rappresentata dall’uso del punto interrogativo nel titolo di copertina. Va comunque detto che questa cautela non impedisce una moderata presa di posizione nel dibattito, sviluppata attraverso l’esame critico di alcuni elementi e passaggi del testo dottrinalmente problematici, nel tentativo di restituire all’opera una prudente compatibilità avicenniana (apprezzabile in questo senso il confronto interpretativo con Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition, Leiden-Boston, Brill, 20142, sviluppato soprattutto nelle note 55-56, 77, 105 e 119). Lascio ad ogni modo ad altri che ne abbiano competenza la considerazione delle questioni di autenticità e di critica del testo, per concentrarmi su alcune delle ragioni di interesse storico e concettuale.
Avicenne (?), Épître sur les prophéties. Texte arabe, introduction par O. L. Lizzini, traduction et notes par J.-B. Brenet, Paris, Vrin, 2018, 197 pp.
Come indica il titolo nella sua completezza (Épître sur l’établissement des prophéties, l’interprétation de leurs symboles et de leurs images) e come chiariscono le pagine introduttive di Lizzini, l’Epistolasi pone il duplice scopo di stabilire l’esistenza della profezia – distinguendone in particolare la veridicità dalla falsità delle favole – e di giustificarne l’impiego di un linguaggio immaginifico e favoloso. L’opera si divide pertanto in due parti: una prima di natura prettamente speculativa, nella quale la rivelazione profetica riceve una necessaria fondazione noetica e metafisica; una seconda di natura esegetica, in cui, attraverso un saggio interpretativo dei simboli e delle immagini della rivelazione, il parlare simbolico e allusivo del profeta è ricondotto a un contenuto intelligibile e funzionale di verità. Le due parti convergono dunque in una rappresentazione unitaria e coerente del fenomeno profetico, dove, se il fondamento della profezia è metafisico e metafisica è anche la sua finalità religiosa e politica (le “leggi” che il profeta instaura, scrive Lizzini, servono, in ultima istanza, alla conservazione della specie umana, garantendo la sua costituzione comunitaria), il linguaggio simbolico assume un valore allegorico che trascende il pur fondamentale carattere retorico e prescrittivo della sua funzione politico-religiosa per farsi espressione della stessa verità metafisica. Cosa che presuppone una prospettiva di stampo razionalistico in linea di principio ben diversa da quella teocentrica della profetologia cristiana, per la quale vale senz’altro il primato epistemico della grazia e della rivelazione, ma che per ragioni profonde di connaturazione – una stessa “metafisica” sostanzia le diverse soluzioni – se ne costituisce almeno in parte come un principio di intelligibilità e di spiegazione. Ed è in questa direzione che vorrei provare ad esprimere rapidamente un paio di considerazioni.
Secondo una prospettiva che si lascia facilmente inquadrare nel pensiero avicenniano la rivelazione profetica è concepita qui come un flusso intelligibile che ha in Dio la sua fonte, nell’intelligenza angelica la sua irradiazione e nell’uomo l’immediato rispecchiamento, ma anche la sua degradazione. Ciò che infatti contraddistingue il profeta è non solo la capacità di ricevere intellettualmente il flusso dall’angelo senza la mediazione dell’insegnamento e del ragionamento, proprio come avviene – spiega l’Epistola – nell’apprensione immediata e non discorsiva dei primi principi, ma anche quella di tradurne simultaneamente le forme in immagini simboliche e sensibili. La visione profetica comporta infatti la percezione sensibile di un dato intelligibile, nella quale il profeta traduce in immagini ciò che di per sé esiste solo intellettualmente (una traduzione/esplicazione non priva evidentemente di fondamento metafisico, se nel flusso della creazione l’essere sensibile è in qualche modo dedotto dall’intelligibile). Avicenna quindi, come dice bene Lizzini, umanizza l’eccezionalità della condizione profetica, riconducendola a un’eccellenza nella dimensione antropologica (e psicologica) della conoscenza e della comunicazione e facendo del profeta, per straordinaria capacità di intuizione e di immaginazione, un filosofo-poeta. Tralascio qui i dettagli con cui l’Epistola, in base al principio di pienezza, prova la necessità della profezia e dell’esistenza del profeta, esistenza senza la quale la scala del sapere umano risulterebbe incompleta. La lettura di queste pagine risulterà senz’altro istruttiva per afferrare il quadro teorico, al contempo noetico e metafisico, in cui si iscrive la prospettiva dell’autore. Quello che invece mi preme sottolineare è la portata epocale di questa naturalizzazione del profeta e del suo privilegiato equilibrio di pensiero e sensibilità, di intelletto e corporeità, variante del grande tema premoderno dell’uomo nobile e bene nato e, in termini cristiani, del predestinato. Vale qui come presupposto il riferimento, opportunamente richiamato da Lizzini, all’idea aristotelica dell’eustochia(Secondi analitici, I, 34; Etica Nicomachea, VI, 9), quella “perspicacia” a cui Avicenna allude altrove, nella trattazione dell’intelletto santo che è anche l’intelletto del profeta (L’anima, V, 6). Secondo Aristotele l’eustochiarappresenta una certa abilità intellettuale che, da un punto di vista logico-filosofico, consiste nella prontezza intuitiva o deduttiva con cui si afferra la causa di un fenomeno o il termine medio di un ragionamento. Una abilità connaturata e perciò in senso proprio un in-gegno. Ma questo spiega, mi sembra, perché in generale secondo lo stesso Aristotele una simile acutezza di pensiero non possa prescindere da un corpo perfettamente naturato e di conseguenza da un’ottima generazione. In più occasioni del resto Aristotele associa intelligenza, corporeità e cause della riproduzione. Nel trattato Sulla generazione degli animali(II, 3) si legge che le anime differiscono specificamente tra loro per nobiltà o ignobiltà in base alla diversa qualità del seme e che (II, 6) la buona complessione (eukrasia) è indicata dal pensiero, motivo per cui l’uomo è il più ragionevole degli animali (o il meglio naturato). Un concetto ribadito nel trattato Sull’anima(II, 9) dove, facendo dell’intelligenza una funzione dell’acutezza del tatto, Aristotele scrive che tra gli uomini quelli che hanno la carne dura sono mal dotati (aphyeis) quanto al pensiero, quelli invece dalla carne tenera sono ben dotati (euphyeis); e ancora neiTopici (VIII, 14), dove sono addirittura i “logici” a essere ottimamente naturati (oi pephykotes eu). Ora questi testi, e soprattutto il primo (di cui L’anima, V, 7 di Avicenna costituisce, mi pare, una trasposizione metafisica), meritano qui particolare considerazione per aver giocato un ruolo decisivo nella costituzione del meccanismo avicenniano della preparazione e del flusso, un modello teorico che non presiede solo alla spiegazione del fenomeno della profezia e della conoscenza umana, ma anche a quello naturale della generazione del mondo sublunare e che come tale è recepito dal pensiero latino medievale, in particolare nella spiegazione dell’infusione divina dell’anima umana. In breve, l’idea (che mi sembra operante nella naturalizzazione del profeta) che la qualità dell’intelligenza sia condizionata dalla qualità del corpo e che la sua “prontezza” sia quindi una questione di natura – dove la natura è a sua volta una questione di nascita e di riproduzione –, fa sì che l’uomo di ingegno (eufues), sia esso filosofo o profeta, risulti determinato da una ragione riconducibile ai modi della generazione, cioè, in termini avicenniani, a una ricezione del flusso condizionata dal grado di preparazione della materia. Un’idea di assoluta portata antropologica, come testimonia il vocabolario latino della gentilezza, termine che riferendosi al sostantivo gensinsiste etimologicamente sul verbo genoo gigno, restituendo un fondamento eugenetico prima ancora che araldico alla nobiltà. L’uomo nobile e gentileè in sostanza il “bene nato”, l’uomo fortunato, colui che è destinato a un’eccellenza morale e spirituale, e quindi filosofica e intellettuale, perché ottimamente naturato. Ma anche e soprattutto, in una prospettiva cristiana, colui che è destinato al bene e cioè il predestinato. Voglio dire, e con ciò sottolineare la rilevanza dell’intuizione avicenniana, che è una stessa matrice genetica, eretta a sistema dal meccanismo della preparazione e del flusso, quella che tra aristotelismo, religione islamica e cristianesimo spiega le eccezionali prerogative spirituali del profeta, dell’uomo nobile e filosofo e del predestinato, come dimostra il caso assolutamente emblematico di Cristo, modello al contempo di elezione, virtù profetica, sapienza e ottima “naturazione”. La cosa d’altra parte non deve sorprendere. A ben vedere infatti nella prospettiva teologica cristiana la natura in quanto creatura ha nella grazia il principio e la condizione non solo del proprio oltrepassamento, ma anche della propria naturale attuazione, per cui è solo nella grazia che la creatura gode di una perfetta integrità e può dunque realizzare la propria perfezione (di nuovo si pensi qui al caso di Adamo). Anche allora in un differente contesto culturale come quello della cristianità medievale, in cui si respinge l’interpretazione razionalista della profetologia avicenniana, insistendo piuttosto sul carattere divino e perciò indebito e predestinato del dono profetico, il modello eugenetico di quell’interpretazione conserva una funzione di intelligibilità. Il fatto è che l’azione divina, anche quando prescinde dalla mediazione della natura, non ne contraddice l’ordine e la razionalità. Dio se dona la grazia, la fonda sempre sulla natura adatta, producendo simultaneamente la preparazione della materia e la forma (cfr. ad es. Tommaso, Summa theologica, II-II, q. 172, a. 3). In breve, creando il profeta dal nulla della sua umana miseria spirituale e morale, lo crea ri-producendo anche la disposizione naturalmente conveniente alla sua funzione. Si capisce allora la coerenza e la profondità speculativa con cui Dante nel IV trattato del Convivio, riducendo l’origine dell’uomo nobile, che altri non è che il filosofo, a un fenomeno di necessità naturale secondo il meccanismo avicenniano della preparazione e del flusso – Dio infonde l’intelletto e con esso il seme della nobiltà solo in quell’organismo naturalmente preparato e quanto più adatto a riceverlo –, faccia della riproduzione la ragione di una nobiltà di nascita che si configura al contempo come perfezione naturale e dono di grazia.
Questo per quanto riguarda quella che a me sembra davvero l’importanza teorica e concettuale della prima parte dell’Epistola, dal punto di vista generale di una archeologia del pensiero medievale. Ma anche la seconda rivela in questa prospettiva delle implicazioni che meritano considerazione.
Come si è accennato, lo stesso è il flusso di verità del quale il profeta e il filosofo si fanno ricettori, ma diversa è la forma della sua comunicazione. Il discorso profetico non procede infatti in modo dimostrativo e neanche dialettico, ma attraverso immagini e suggestioni sensibili; e proprio per questo si impone l’esigenza – di cui si fa carico la seconda parte dell’Epistola– di una sua giustificazione. Si tratta di un punto concettualmente decisivo e in cui precipita e si annida tutto il platonismo che contraddistingue la profetologia avicenniana e, più in generale, il pensiero filosofico nell’Islam medievale. Attraverso il carattere al contempo descrittivo e prescrittivo del discorso profetico è infatti il nesso che in Platone vincola metafisica, etica e politica ad essere riattualizzato e con esso una strategia razionalistica non solo di conoscenza ma anche di educazione e comunicazione. Se la rivelazione profetica degrada e traveste in immagini il flusso intelligibile è perché essa deve innanzitutto persuadere ed educare l’uomo comune all’osservanza della legge divina. Si tratta, per dirla con Lizzini, dell’aspetto propriamente pratico e prescrittivo della rivelazione, che rimanda al suo primato politico (instaurazione della legge) e religioso (instaurazione della fede). Un primato per il quale è fatto valere un consapevole e originale approccio sociologico alla comunicazione, sul modello dell’analisi psicosociale a cui nella Repubblicae nelle Leggi– testi, sia detto per inciso, ignoti alla coeva tradizione latina – sono sottoposti i generi letterari del mito e della poesia. Del tutto appropriato allora il rimando di Brenet al Trattato decisivo di Averroè, dove un analogo approccio sociologico alla comunicazione è eretto a sistema nel quadro di un avanzato e impressionante accordo tra Islam e filosofia, e dove alla rivelazione è attribuito il compito di radicare i principi della verità e della giustizia negli animi dei fedeli attraverso una strategia di travestimento e condizionamento retorico e poetico modellata sulla mitopoiesi platonica. D’altra parte, però, se la narrazione profetica propone in forma mitica e simbolica una verità intelligibile, se la fondazione della profezia è metafisica, del tutto coerente e naturale appare la possibilità inversa di risalire dal simbolo alla verità, dal mito al logos,ritraducendo i dati religiosi in termini filosofici e restituendo natura dialettica e intelligibile alle immagini simboliche. È quella che Lizzini definisce la dimensione propriamente descrittiva della rivelazione, nella quale si espone e rappresenta il contenuto della fede e il cui senso profondo è ri-attingibile attraverso la filosofia. Ecco la coerenza della profetologia avicenniana (ma anche averroista) e del suo razionalismo, che attribuisce al sapere intellettuale che la fonda la chiave esegetica più autentica del testo rivelato!
Nell’Epistola‘Avicenna’ offre più di un saggio interpretativo di questo peculiare allegorismo filosofico, restituendo ad alcun simbolismi coranici (Cor., XXIV, 35; LXIX, 17; LXXIV, 30) un significato immediatamente “aristotelico”. Ciò che colpisce di questa ermeneutica filosofica e che la distingue radicalmente da un analogo uso del sapere filosofico nella riflessione teologica ed esegetica cristiana (forse qualcosa di vagamente simile può essere rappresentato da certa interpretazione secundum phyisicam del racconto biblico della creazione in voga nella prima metà del XII secolo), è l’effettivo primato riconosciuto alla ragione aristotelica, su cui si fonda e si articola la specificità del concordismo filosofico nell’Islam medievale (ma anche nella coeva filosofia ebraica). Diversamente nel mondo cristiano la superiorità epistemica della rivelazione non può essere messa in alcun modo in discussione. E l’errore di chi si serve della filosofia – scrive ad esempio l’“aristotelico” Tommaso – è proprio quello di costringere entro i suoi limiti ciò che è proprio della fede, quando è invece «la filosofia a dover essere ricondotta entro i limiti della fede» (Commento al libro di Boezio sulla Trinità, q. 2, a. 3). Nella prospettiva dell’Epistola, invece, il sapere filosofico si costituisce come una sorta di codice ermeneutico in base al quale è possibile restituire, attraverso l’uso sistematico dell’allegoria, un senso intelligibile e razionale al versetto coranico. Giustamente quindi Lizzini sottolinea come la trasposizione del religioso nel filosofico avvenga attraverso un vero fenomeno di interpretazione, nel quale l’intero sforzo consiste nel ricondurre il linguaggio simbolico alla coerenza della ragione. Il primato, come si è detto, spetta alla filosofia e il linguaggio religioso dice il vero nell’esatta misura in cui si lascia ridurre a un’interpretazione filosofica. È chiaro però che questo è reso possibile anche da un preliminare e storicamente decisivo lavoro di preparazione e adattamento del sapere filosofico, sapere che nel mondo islamico medievale appare incentrato sulla filosofia della tarda antichità e caratterizzato, attraverso la funzione pseudoepigrafica del Plotino e del Proclo arabo, da un intemperante processo di platonizzazione e teologizzazione dell’aristotelismo. L’Aristotele dell’Epistola, chiamato a legittimare l’esistenza della profezia e a restituire intelligibilità metafisica alle immagini della rivelazione, è un Aristotele che si fa carico di un’ontologia gradualistica – per altro lo stesso Aristotele, non ci si stancherà di ripeterlo, che comanda il pensiero latino medievale. Emblematico in questo senso la trasposizione del cosiddetto argomento della “causalità del massimo” con cui in apertura l’Epistoladeduce la necessità della profezia. Messo giustamente in evidenza da Brenet, questo argomento, di matrice aristotelica (Metafisica, II, 1, 993b25-31) e celebre anche per il ruolo giocato nella quarta via di Tommaso, consente all’autore di iscrivere l’anima dell’uomo e del profeta in particolare in una unità genealogica di derivazione e partecipazione, trasponendo il lessico aristotelico della potenza e dell’atto e la teoria dell’intelletto in una «topografia metafisica» di evidente ascendenza neoplatonica. Ed è anche in questa epocale trasformazione di Aristotele che consiste l’importanza archeologica di questo piccolo gioiello della profetologia “avicenniana”, il quale, concludendo, testimonia quindi non solo la naturalità della dote profetica e la peculiare fondazione metafisica nell’Islam medievale della rivelazione e del suo simbolismo allegorico, straordinaria forma di risignificazione di un platonismo autentico e radicale, ma anche lo sforzo attivo di appropriazione del sapere filosofico antico che quella fondazione presuppone e che la traduzione e il commento sapiente dei curatori riesce a restituire in tutta la sua ricchezza e complessità.



