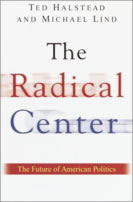Una tragedia degli errori (Neocon e vecchie menzogne)
|
|
Micromega/Filosofia.it
Un’ideologia politica può fallire nel mondo reale solo un certo numero di volte prima di essere del tutto screditata. E da almeno vent’anni i neocon hanno torto su ogni questione di politica estera (Iraq incluso), come qui dimostra, analizzandone errori e menzogne, l’ex executive editor di uno dei maggiori periodici neocon. (traduzione e note di Silvia Pareschi)
(1) «Adversary culture» è una definizione coniata da L. Trilling in Beyond Culture (1965) (ed. it. Al di là della cultura, a cura di G. Fink, Firenze 1980), per indicare la tendenza degli intellettuali di sinistra americani a criticare con esasperata ostilità il proprio paese.
|
Cerca tra le risorse
 Giornale Critico di Storia delle Idee
Giornale Critico di Storia delle Idee La filosofia futura
La filosofia futura
Rivista di filosofia teoretica
__________MULTIMEDIA__________
![]() VIDEO
VIDEO
Filippo Mignini
Spinoza: la potenza della ragione
(Emsf)

Gennaro Sasso
Giovanni Gentile: la filosofia, la politica
(Treccani Channel)
Focus
-
 Laicità e filosofia Che cosa significa essere laici nel nostro Paese, dove forte è l'influenza politica della Chiesa? Grandi personalità del pensiero e della cultura riflettono, per la prima volta insieme, su questa questione...vai alla pagina
Laicità e filosofia Che cosa significa essere laici nel nostro Paese, dove forte è l'influenza politica della Chiesa? Grandi personalità del pensiero e della cultura riflettono, per la prima volta insieme, su questa questione...vai alla pagina
- 1
- 2